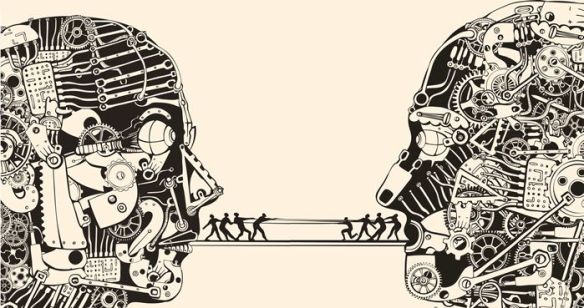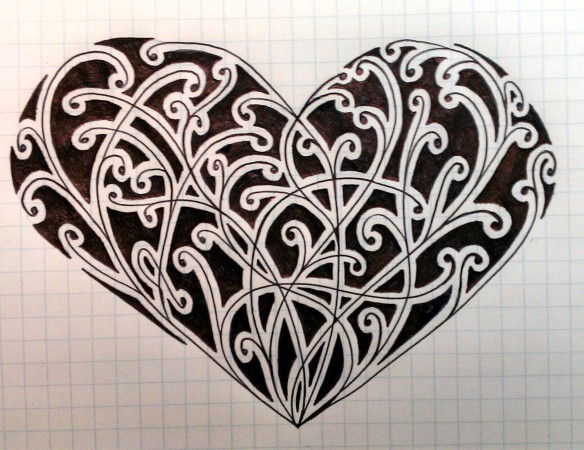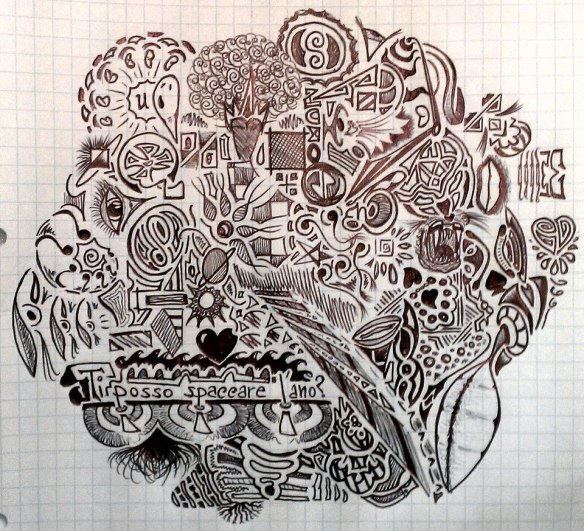Ormai è passata più di mezz’ora da quando abbiamo iniziato a deglutire la saliva amara, succhiando il nostro particolare francobollo colorato. Finalmente avverto una piacevole sensazione di calore che mi pervade e mi abbandono su una sedia fermandomi un attimo a guardare cosa succede intorno a me: sono in compagnia della mia insostituibile sorellina e di G. e siamo appena usciti dal Tate Modern di Londra, a causa di un non ben definito bisogno di aria. Loro due sono entrati nel bar alle mie spalle, e io mi sono seduto sulle sedie esterne, al freddo. Ha anche smesso di piovere, e tutto è stranamente quieto.
Dopo un po’ chiudo gli occhi per rilassarmi e succede incredibilmente che continuo a percepire, nitide, le immagini che normalmente avrebbero dovuto essere sostituite da un omogeneo colore nero, il colore che si vede abitualmente ad occhi chiusi. Apro nuovamente gli occhi e non avverto la tipica sensazione di passare dal buio alla luce, perché anche un attimo prima per la mia mente era come se stessi guardando qualcosa. Quindi non un netto stacco, ma una sorta di passaggio sfumato, due modi diversi di poter percepire immagini visive: uno ad occhi aperti, più concreto, più normale, e uno ad occhi chiusi, più etereo, più strano. Dico strano perché mentre ad occhi aperti la sensazione è ancora quella di percepire un mondo normale, ad occhi chiusi si avverte immediatamente la libertà creativa del proprio cervello, che inizia a formare tutto un intrico di forme e colori a partire dall’ultima immagine osservata ad occhi aperti: linee colorate che si rincorrono ed incastrano, motivi geometrici che mutano caleidoscopicamente in un continuo divenire di nuove forme e colori, e tutto accompagnato da una sorta di ritmo di fondo, una specie di profondo battito pulsante. Evidentemente la parola “realtà” comincia a farsi incerta, inafferrabile, dato che si avverte in maniera chiara e distinta che è solo il nostro sistema percettivo che ci informa di come sia fatto il mondo esterno, di come ci appaia. Quindi ora che abbiamo tutte le percezioni distorte risulta distorta anche la realtà: quella realtà con cui abbiamo convissuto per tutta la vita, di punto in bianco viene sostituita da un’altra realtà, che a partire dagli stessi input viene manipolata arbitrariamente dal proprio cervello per formare qualcosa di assolutamente unico e irripetibile, sorprendentemente nuovo ed eccitante.
Riapro gli occhi e cerco di alzarmi: devo dire a mia sorella e a G. di chiudere le palpebre per verificare se anche a loro succede quello che sta succedendo a me, ma faccio appena in tempo ad alzarmi dalla sedia che mi sale un repentino conato di vomito e mi ritrovo piegato a espellere bile, con mia sorella che mi chiede “Come stai? Tutto bene?” Ho appena vomitato, eppure sto benissimo, sono sfasato e felice “Guarda quel palazzo a vetri, è assurdo”, e glielo indico, vomitando di nuovo.
Quando mi rialzo, pochi secondi dopo, mi basta uno sguardo rapido per capire che ormai il viaggio è iniziato: sono nel Paese di Alice e non mi resta altro da fare se non godere delle sue Meraviglie, accompagnato dai miei due preziosissimi compagni di viaggio.
Essendo noi umani creature fondamentalmente visive*, chiaramente la distorsione avvertita con maggiore intensità è proprio quella visiva: qualsiasi cosa intorno a noi possiede una vita propria, una fondamentale concretezza che mai avevamo notato. Esempio emblematico sono i vetri, gli specchi e le pozzanghere: i loro allucinanti riflessi sembrano possedere una propria esistenza indipendente dal fatto di essere “solo” un riflesso di qualcosa di reale. Anche i semplici riflessi appaiono tangibili, reali, dotati di sostanza: verrebbe voglia di dire che non sono affatto dei semplici riflessi, ma che sono delle cose vere, che esistono.
D’un tratto ecco presentarsi un’altra sensazione che pervade me e mia sorella, ma non G.: si tratta di una sensazione di gioia, di calore, di felicità, focalizzata sulla parte meno nobile del nostro corpo, e cioè il buco del culo. Lo si avverte felice, appagato di essere l’orifizio finale di tutto. Una specie di gioia legata al solo fatto di possedere un ano in grado di dilatarsi e di defecare al momento giusto. Tutto ciò ha poco a che fare con la fase anale di freudiana memoria, è più una sorta di inspiegabile felicità che scaturisce dai muscoli dell’ano, di genuina gioia anale… e la causa è solo ed esclusivamente la merda. Sulla questione ci abbiamo riflettuto in due, sia durante che dopo il viaggio, e il miglior modo di descriverla che abbiamo trovato è: “felicità di merda” (e tutto ciò coincide anche con il primo utilizzo interamente positivo della specificazione “di merda” di cui io abbia mai avuto esperienza, anche indiretta).
Una volta capito che è proprio questa la sensazione che entrambi stiamo provando decidiamo all’unanimità di tornare verso casa, ma per farlo abbiamo bisogno di sapere come tornarci e quindi chiediamo indicazioni. È il nostro primo contatto con le altre persone, le persone normali, e si rivela più incredibile di quello che ci aspettassimo: ogni singola persona appare mostruosamente pittoresca, al contempo grottesca e comica, troppo assurda per essere vera… eppure eccoli tutti lì, vivi e veri, davanti ai nostri occhi: il loro modo di camminare, di parlare, di vestire, di ridere, di guardare l’orologio… ogni cosa che fanno la fanno in maniera atipica, quasi forzata, come se seguissero un copione assurdamente complicato scritto da un autore di spicco del frangente più estremista del teatro d’avanguardia. Non hanno senso. Nessuno di loro ha senso.
Eppure non sono loro: siamo noi.
E lo sappiamo benissimo, è questo il punto: per tutta la durata del viaggio continuiamo a sapere di essere nello stesso mondo di sempre, reso diverso solamente dalla deformazione indotta dei nostri canali percettivi… eppure è tutto talmente reale, talmente assurdo e al contempo convincente che si finisce per rimanere per ore in uno stato di passiva contemplazione di tutto, del mondo intero. A tratti ci sono anche dei momenti di completa lucidità, in cui tutto sembra essere tornato normale, e quindi ci si ritrova in silenzio, ad osservare con l’occhio attento delle prede tutto quello che ci circonda, illusi di aver ritrovato un barlume di controllo. Poi, in un attimo, le pareti cominciano a non sembrare più proprio normali, e anche il pavimento inizia nuovamente a formare sotto i nostri occhi strane forme geometriche che vanno e vengono… “È tutto un po’ strano”, dice G., racchiudendo in così poche parole l’essenza della sensazione che si prova per tutta la durata del viaggio: il mondo a tratti sembra quello di sempre, eppure no… c’è sempre qualcosa che non va, qualcosa di ineffabile, di misterioso, che rende l’intera propria vita percettiva (e quindi mentale) piacevolmente aliena e inusuale. Come cazzo fa un muro ad essere inusuale? Provare per credere.
Durante il viaggio in metro continuiamo ad osservare tutta una florida fauna al limite del mitologico: individui troppo onirici per essere veri, eppure ben saldi di fronte ai nostri occhi stupiti. Ho motivo di credere che la sensazione sia affine a quella di un naturalista che sbarcasse per la prima volta in un mondo nuovo, popolato da creature mai viste prima: sì, Darwin deve aver avuto la stessa identica sensazione quando sbarcò per la prima volta alle Galapagos! Ad un certo punto la metro attraversa un tratto allo scoperto e in quel momento esce il sole, un bel sole caldo, che fa risaltare tutti i colori che ci circondano: in particolare notiamo la vividezza dei colori brillanti e mia sorella diventa improvvisamente felice (di una felicità genuina, a 360 gradi) a causa della “verdezza” del colore verde di uno dei tubi che le persone utilizzano per tenersi saldi. È di un verde talmente acceso, di un verde talmente brillante, di un verde talmente VERDE che mia sorella è felice di poter essere lì ad osservarlo: non serve altro, per la sua felicità, della verdezza di quel verde. Non dimenticherò mai il suo volto eccitato e gioioso, al limite del comprensibile. E ogni volta che ripenso alla causa di tale felicità (la verdezza del verde) mi ritrovo immancabilmente a sorridere: non potrò mai più guardare qualcosa di verde senza ripensare alla gioia di mia sorella e quindi rivivere una parte di quella felicità. Epico.
Tale è il livello di novità durante la percezione del mondo, che si fa fatica a descriverlo. Ed è una difficoltà che non sopravviene solo una volta che il viaggio è terminato, ma è una difficoltà frustrante che ci accompagna per tutta la sua durata: le percezioni visive uditive e tattili si accavallano formando nella mente delle “immagini” talmente complesse e particolareggiate, e insieme mutevoli, che ogni tentativo che facciamo di provare a descriverne agli altri anche una minima parte risulta immediatamente insoddisfacente, lasciandoci di punto in bianco senza parole, in silenzio, arresi al fatto che comunicare verbalmente una realtà non verbale è una sfida che non possiamo vincere, che nessuno potrà mai vincere**.
Infatti chi ci guarda da fuori ci giudica distratti, distanti, non propriamente presenti a noi stessi… ma il punto è un altro: la nostra attenzione è talmente attratta dalla moltitudine di cose nuove, mai viste prima, che il dover prestare attenzione ad una voce che parla passa immediatamente in secondo piano se confrontato con la voglia di prestare attenzione a tutto ciò di cui è popolato il mondo che ci circonda: ogni capello di chi ci parla, ogni mattone del muro più vicino, ogni pozzanghera, ogni nuvola… letteralmente OGNI cosa che ci circonda risulta incredibilmente affascinante e aliena: quelle che erano sempre state normali fantasie sui tessuti diventano improvvisamente delle fantasie dettate dall’estro di un genio artistico, e un identico giudizio entusiasta viene rivolto alle imperfezioni della strada, stranamente ordinate e geometriche, alle increspature di una parete verniciata, stranamente vive, alle venature di un braccio, completamente perfette… il tutto sempre accompagnato dalla sensazione accennata poco sopra, quella legata alla gioia della merda (e quindi si capisce che tale sensazione non combacia affatto con la voglia di defecare, dato che nessuno di noi ha mai avuto intenzione di andare in bagno a liberarsi: è una sensazione piacevole che ci accompagna, ecco tutto). Come potreste prestare attenzione a qualcuno che vi chiede qualcosa quando, all’improvviso, TUTTO il mondo vi appare formato da minuscoli numeri colorati? Come quei dipinti costituiti da una moltitudine di puntini colorati, dai quali emergono figure ben definite, distinte… solo che questa volta non è un’immagine in due dimensioni, come un paesaggio che emergesse dai puntini, ma è il mondo intero che emerge da una moltitudine di piccolissimi numeri colorati e addossati gli uni sugli altri in maniera perfettamente coerente. E questo è solo uno dei tanti flash che ho avuto, che si accavallano continuamente l’uno sull’altro senza soluzione di continuità, in un incessante divenire, la cui velocità di cambiamento è talmente elevata che provare a descriverlo in diretta è praticamente impossibile.
 D’un tratto eccolo, il colpo di genio: guardo mia sorella e le dico “Ho capito! Finalmente so perché i Pink Floyd si chiamano così”. Lei mi rivolge lo sguardo e mi sorride eccitata, aspettando il responso. “È la gioia della merda, sister. Tu come disegneresti la sensazione che ci sta accompagnando dal museo?” le domando. E lei mi risponde: “Con una cacca che ride, felice” “Che ne dici di una cacca rosa?” “Perfetto”. Il fluido cui si riferirono i ragazzi di Londra è proprio la merda, ora lo so. Ora ne sono sicuro. E il rosa è dovuto alla gioia: quale colore può racchiudere la felicità meglio del rosa? Nessuno, evidentemente. Pink Floyd: fluido rosa, merda rosa, merda felice.
D’un tratto eccolo, il colpo di genio: guardo mia sorella e le dico “Ho capito! Finalmente so perché i Pink Floyd si chiamano così”. Lei mi rivolge lo sguardo e mi sorride eccitata, aspettando il responso. “È la gioia della merda, sister. Tu come disegneresti la sensazione che ci sta accompagnando dal museo?” le domando. E lei mi risponde: “Con una cacca che ride, felice” “Che ne dici di una cacca rosa?” “Perfetto”. Il fluido cui si riferirono i ragazzi di Londra è proprio la merda, ora lo so. Ora ne sono sicuro. E il rosa è dovuto alla gioia: quale colore può racchiudere la felicità meglio del rosa? Nessuno, evidentemente. Pink Floyd: fluido rosa, merda rosa, merda felice.
Usciamo finalmente dalla metro e ci dirigiamo a piedi verso l’ostello in cui alloggiamo, accompagnati dall’immancabile G. Nonostante il passare del tempo sembra impossibile abituarsi al fatto che le proprie percezioni siano distorte e quindi, liberi sulle nostre gambe, continuiamo il nostro viaggio incantato che ci separa da “casa” e rimaniamo assorti (complice un bel sole caldo) a contemplare le case, i tetti, i marciapiedi, le piante, le automobili, le sirene, gli gnomi, i nani, i mostri: è tutto normale, eppure è tutto indescrivibilmente eccitante, bellissimo. E viviamo tutto quello che accade non come se fossimo anche noi parte del mondo, ma lo viviamo come si potrebbe vivere un’estrema esperienza cinematografica fatta di ologrammi ed effetti speciali in 3D: tu lo sai che non sono veri, eppure sembra proprio che quel sasso ti colpirà, a meno che tu non chini la testa in fretta: e più l’effetto è realizzato a dovere, più vengono ingannate le nostre percezioni, e più saremo portati a “schivare” il sasso in maniera istintiva, non ragionata. Ecco, nel Paese delle Meraviglie è la stessa sensazione di non-partecipazione, ma amplificata a dismisura: ci si sente spettatori stranamente olografici di un mondo non propriamente reale, costruito ad hoc per sorprenderci da tutte le direzioni ed in tutti i modi possibili.
Per entrare in ostello passiamo attraverso il solito stretto corridoio che separa il nostro edificio da quello adiacente e lì ci immobilizziamo: quel corridoio strettissimo, al limite del soffocante, ora è largo, spazioso, quasi troppo. E quindi restiamo fermi, a cercare di capire cosa ci sia di diverso nella nostra percezione da farcelo apparire così diverso rispetto al solito: dall’interno del corridoio, guardando verso l’entrata o l’uscita, si percepisce distintamente una sensazione di tanto spazio disponibile, come se i muri verticali fossero improvvisamente incurvati a formare uno spazio più ampio e tondeggiante. Poi basta girare la testa verso il muro ed invece quello è lì, ad un palmo dal proprio naso, costituito da strani mattoni rossi e pelosi, pelosissimi: esattamente come quando si zooma una superficie apparentemente liscia e si iniziano a distinguere le sue increspature ed imperfezioni, anche ora abbiamo l’impressione di poter vedere in alta definizione, di poter distinguere in maniera immediata le imperfezioni dell’argilla cotta e di vederne così la struttura fine, microscopica, accidentata, che dà appunto l’idea di essere ricoperta di peli morbidi, quasi come se fosse un mattone di peluches morbido alla vista, eppure duro al tatto.
Finalmente entriamo in ostello e saliamo le scale che ci portano al secondo piano: dopo aver percorso la prima rampa sembra che la gravità non punti più verso il basso, ma che punti un po’ di lato, verso l’esterno della curva che compiamo per salire le scale… che strano. Arriviamo nella sala del secondo piano e ci appartiamo in un angolo della saletta relax, mantenendo le dovute distanze dagli altri presenti: è già difficile comunicare tra noi tre, che siamo tutti insieme nel mondo di Alice… figuriamoci descriverlo agli altri, abitanti del mondo normale. Impossibile.
Dopo qualche minuto la mia preziosa sorellina mi si avvicina e mi dice con aria preoccupata che le sue sensazioni non sono sempre positive, soprattutto quando si trova a doversi relazionare con le altre persone: a tratti sta male, mi dice che non si sente completamente a posto, che prova qualcosa di simile al disagio, “Come se ci fossero qui mamma e papà”, mi dice. Questa frase mi fa capire al volo cosa intende, e fortunatamente riesco subito a focalizzare l’attenzione sulla medesima sensazione che anche io stavo provando da tempo: “Ari, ho la stessa sensazione da quando siamo arrivati in ostello. Chi cazzo è sta gente che mi gira intorno? E perché mi guardano? Conosco le risposte a queste domande, eppure il disagio permane, inalterato”. “Ah quindi lo senti anche tu?!?” e mi abbraccia fortissimo, felice di non essere lei, quella strana. Qui è tutto strano, incredibilmente strano.
Distesi sui morbidi puff sparsi un po’ ovunque nella sala, capiamo che per trovarsi nel Paese delle Meraviglie non è tanto importante che tu sia al Tate Modern o dentro ad un gabinetto di un autogrill: quando le tue percezioni sono distorte, sballate, ti basta poco, pochissimo, per sorprenderti a fissare il mondo con occhi diversi, con rinnovato e inappagabile stupore. Bastano le proprie mani, o il colore verde…
 Ad un certo punto mia sorella si stende vicino a me, cercando di frenare un po’ la sua vulcanicità di energia interminabile e io l’abbraccio, nel tentativo di rasserenarla con qualche carezza da fratello maggiore e protettivo: è in grado di sprigionare più energia lei in mezz’ora che io in mezza giornata, non ci si crede. Poi la mia esplosiva sorellina gioca il jolly e conferisce una colonna sonora ai nostri pensieri caleidoscopici e mutaforma: dal suo portatile inizia a farsi largo The Dark Side Of The Moon… perfetto. Assolutamente perfetto.
Ad un certo punto mia sorella si stende vicino a me, cercando di frenare un po’ la sua vulcanicità di energia interminabile e io l’abbraccio, nel tentativo di rasserenarla con qualche carezza da fratello maggiore e protettivo: è in grado di sprigionare più energia lei in mezz’ora che io in mezza giornata, non ci si crede. Poi la mia esplosiva sorellina gioca il jolly e conferisce una colonna sonora ai nostri pensieri caleidoscopici e mutaforma: dal suo portatile inizia a farsi largo The Dark Side Of The Moon… perfetto. Assolutamente perfetto.
Siamo tutti e tre lì, silenziosi, assorti nei nostri pensieri autocritici: ormai si è in qualche modo affievolita, o comunque sta lentamente diminuendo tutta la parte del viaggio legata alla distorsione della percezione, e quella sensazione viene man mano sostituita da qualcosa di più riflessivo, di ponderato, di personale. Ad un tratto, mentre mi ritrovo a fissare quelle strane lampade formate da alcuni neon e da alcuni specchi incrociati (realizzando che più una mente è profonda e più il Paese delle Meraviglie gli apparirà meraviglioso), mia sorella mi stringe forte e inizia a piangere, con gli occhi chiusi. Io sono stranamente rilassato invece, nonostante le sue lacrime: ho il mio filo del discorso da seguire e quindi mi limito ad abbracciarla fortissimo e a coccolarla, accarezzandole i capelli e asciugandole le lacrime. Poi ci ripenso, e mi dico che provare la sensazione del pianto potrebbe essere fantastico, e verbalizzo subito questo pensiero: “Cazzo sister, vorrei piangere anche io ora, qui con te” e, testimone G., inizio a piangere disperatamente pochi secondi dopo. Un pianto genuino, disperato, risolutivo: uno dei pianti più disperati di cui abbia memoria, arrivato così all’improvviso, senza preannuncio, e tale da farmi singhiozzare violentemente e produrre una quantità di muco che raramente si è vista produrre da un solo naso. Forse Cyrano… no, nemmeno lui reggerebbe il confronto. Dopo alcuni minuti di disperazione totale mi calmo un po’, quanto basta per riuscire a deglutire e parlare e mentre nella mia mente si arrovellano figure di conigli bianchi, muscolosi e deformi, pieni di artigli e di denti affilati, sfumati qua e la di blu metallico, le dico: “Sister, ora so una cosa importante, e devo riuscire a dirtela bene. Se nel momento più tragico della mia vita io dovessi scoppiare nel pianto più disperato possibile, manifestazione ultima del mio dolore, so che l’unica persona al mondo che potrebbe capire quello che sto provando saresti tu”. E abbiamo continuato a piangere e ridere per alcuni minuti, alternando felicità e disperazione, tenendoci stretti e saldi l’uno all’altra finché non ci accorgiamo che anche G. aveva iniziato a piangere silenziosamente accanto a noi, per cui abbiamo istintivamente allargato le braccia e trasformato un pianto doppio in un pianto triplo, un pianto comune. “Hai detto una cosa bellissima Lu’” (anche lui ha una sorella, tra parentesi), mi dice G., e io non so perché scoppio a ridere, felice.
Trascorre un po’ di tempo e il pianto passa, ci passa a tutti, complice anche il fatto che sta per arrivare M., sorella di G., a salutarci. Poco prima del suo arrivo Arianna e G. escono a fumare e io resto solo, in contemplazione silenziosa e accompagnata dalla musica. La mia attenzione si concentra su un altro pensiero che ho da tempo, che riassume un po’ la mia concezione del rapporto uomo-donna, e del dolore: ogni rarissima volta che la vita mi sembra al limite del sopportabile, che quasi quasi verrebbe da pensare che non ne valga la pena, mi sforzo di figurarmi come sarebbe la mia vita se fossi stata una donna, abituata una volta al mese al completo disagio fisico, e spesso al dolore snervante… e tutto questo senza fare menzione del fatto che chiaramente avrei dovuto scontrarmi quotidianamente con la necessità di dimostrare che valgo molto di più dei miei colleghi maschi, affinché venga riconosciuto che valgo tanto quanto loro. Questo pensiero negativo, paradossalmente, mi aiuta nei momenti peggiori: dico a me stesso “Ricorda che poteva andare peggio Lu’, molto peggio… avresti potuto avere il ciclo, ora”. E scoppio nuovamente a piangere, colpevole solo di aver pensato che a volte la mia vita mi sembra insopportabile quando c’è chi, nei miei panni, vedrebbe solo rose e fiori. Prendo al volo il cellulare e compongo un messaggio, destinato a mia sorella, che sta fumando due piani sotto: “Sei il mio esempio di Forza: quando cerco uno stimolo per tenere duro, io penso sempre a te”, e mi metto a contemplare, in attesa che lei e G. tornino su e che il viaggio finisca, bellissimo e devastante.
_____NOTE_____________________________________________________
*Per gli antichi Greci, iniziatori della filosofia e della scienza, il verbo “conoscere” condivide la radice col verbo “vedere”, ce lo ricorda anche l’enunciato di esordio del primo libro della metafisica di Aristotele: L’uomo tende per natura alla conoscenza.
**Sull’apparente concretezza del linguaggio, data dal fatto che lo utilizziamo quotidianamente per vivere e confrontarci coi nostri simili, essa risulta semplicemente dal fatto che cultura per cultura gli uomini si siano abituati ad attribuire etichette particolari a certi oggetti, a certi colori, a certi suoni, a certi odori, eccetera. Ma è risaputo che non si può descrivere un sapore se non tramite un altro sapore simile, o un odore tramite un altro odore che lo ricordi molto bene. È la classica questione del comunicare verbalmente una realtà non verbale. Chiaramente se ci fosse una cultura che avesse costruito e affinato il proprio linguaggio nel Meraviglioso Paese di Alice avrebbe lo stessa illusione che “il linguaggio funzioni per davvero”, ma basterebbe una piccola percezione distorta, nuova per quella cultura linguistica, da rendere muti tutti i suoi possessori, impossibilitati a descrivere quello che di cui stanno facendo esperienza.